Può sembrare paradossale ma c’è chi fa fronte alla sofferenza psichica procurandosi del dolore fisico.
Questo comportamento, chiamato self-harm, è un fenomeno controverso, difficile da definire, che ha un background psicologico difficile da esplorare e sopratutto è spesso erroneamente definito come tentativo di suicidio. I self-harmer non vogliono morire bensì continuare a vivere cercando di far fronte ai sentimenti negativi ed i ricordi che provocano loro un’intensa sofferenza; dopo aver provato questo metodo per diminuire la tensione non riescono più a smettere, il loro corpo ne ha fisiologicamente bisogno e neanche la loro mente riesce a farne più a meno. Il dolore li fa stare bene, il sangue li fa stare bene anche il solo gesto di tagliarsi li fa stare bene; non tentano il suicidio, quindi, anche se a volte rischiano la vita.
“[L’automutilazione] non celebra la morte ma piuttosto la volontà di vivere. Testimonia la lotta del genere umano per mantenere l’equilibrio. Perciò, caro lettore, empatizza pure, se puoi, con le povere anime che sono vittime dell’automutilazione ma conserva il tuo dolore per i morti” (Favazza, 1996).
Questo è un fenomeno poco conosciuto e spesso sottovalutato ma non per questo bisogna considerarlo poco diffuso: in media nel mondo avviene un suicidio ogni 40 secondi (14,5 casi su una popolazione di 100.000 persone, statistiche WHO), i casi di self-harm sono almeno 1000 volte più frequenti (Favazza, 1996). Per la sua allarmante incidenza e per il fatto che è spesso mal classificato, e quindi erroneamente trattato, è importante che questo fenomeno venga ben definito nelle sue peculiarità. Molti autori l’hanno fatto in passato ed il loro punto di partenza è stato sempre quello di chiarire cosa il self-harm non è: non è un tentativo di suicidio, non è necessariamente associato ad una sindrome principale ed infine, non è sempre un sintomo del Disturbo Borderline di Personalità. La definizione maggiormente accettata al giorno d’oggi è quella di Favazza secondo la quale l’automutilazione è una “deliberata distruzione o alterazione del proprio tessuto corporeo in assenza di un cosciente intento suicida”. In questa definizione è evidente che l’autore punta a sottolineare lo scopo del self-harmer: vuole (“deliberatamente”) farsi del male ma non vuole (“coscientemente”) uccidersi, il suo fine ultimo è la sopravvivenza. Chi si toglie la vita non vede altra soluzione alla propria condizione, chi si ferisce invece, trova una soluzione che, seppur maladattiva, gli permette di continuare a vivere; per questo motivo il fenomeno dell’automutilazione ha anche preso il nome, fra gli altri, di “antisuicidio”.
Nonostante resti centrale l’importanza dell’unicità di ogni individuo, e quindi senza scadere nella mera etichetta nosografica, è possibile tracciare un profilo che racchiude in linea di massima le caratteristiche del self-harmer:
invalida e disprezza fortemente se stesso;
è ipersensibile al rifiuto;
prova cronicamente rabbia, di solito verso se stesso, e la sopprime;
ha mancanza del controllo degli impulsi;
ha alti livelli di aggressività che dirige verso se stesso;
tende a non pianificare il futuro;
può essere depresso e con tendenze autodistruttive;
soffre di ansia cronica;
è facilmente irritabile;
non ha un repertorio flessibile di abilità di coping;
non crede di avere il controllo sulla gestione della propria vita;
si sente privo di potere;
tende ad essere evitante ed agire secondo l’umore del momento.
Ci sono in oltre buone probabilità che:
sia di età compresa tra i 15 ed i 25 anni;
sia una donna;
soffra di disturbi psichiatrici come Depressione, Disturbo Bipolare, Disturbo di Personalità e Schizofrenia;
abbia una diagnosi aggiuntiva di Bulimia o Anoressia.
Nonostante queste distinzioni e chiarimenti, resta una confusione concettuale sul gesto del ferirsi come strategia di coping: non tutti i gesti autolesivi vanno considerati self-harm. Tutti noi assumiamo comportamenti che sappiamo essere nocivi alla nostra salute, eppure perseveriamo nell’attuarli perché il nostro intento primario è solitamente tutt’altro che fare del male a noi stessi. Un’altissima percentuale di noi beve caffé, fuma sigarette o consuma alcolici pur sapendo che danneggiano la salute. Alcuni comportamenti autolesivi sono quindi culturalmente accettati, altri invece non lo sono e vengono dunque definiti come patologici. Naturalmente la gamma di comportamenti culturalmente sanciti muta a seconda della comunità e del periodo storico in cui vengono presi in considerazione.
E’ allora possibile tracciare una linea di confine fra le due tipologie? Potrebbe apparentemente sembrare semplice: potremmo dire che tagliarsi l’avambraccio con la lama di un coltello è un comportamento chiaramente automutilativo e che il fumare, essere in grave sovrappeso e consumare alcolici sono comportamenti che danneggiano il nostro corpo ma non nell’immediato futuro e non direttamente, quindi non patologici. Che dire allora dei tatuaggi, piercing e tali modificazioni corporee? Il gesto di tatuare il proprio corpo include il danno al proprio tessuto corporeo, l’intenzionalità dell’atto e l’assenza di commettere suicidio. Deve rientrare fra i comportamenti patologici?
A questo proposito si possono distinguere diverse possibili forme di di self-injury (Babiker e Arnold, 1997). Nella definizione di self-harm può rientrare una moltitudine di comportamenti quali:
espressione somatica di sentimenti,
disturbi fittizi,
comportamenti autodistruttivi,
automutilazione,
self-harm,
strategie di “miglioramento” del corpo.
La differenza più evidente fra i comportamenti automutilanti e i disturbi psicosomatici e quelli fittizi consiste nell’intenzionalità dell’atto: il self-injurer danneggia se stesso intenzionalmente e direttamente, colui che invece somatizza il dolore psicologico, naturalmente non lo fa intenzionalmente. Per “miglioramento del proprio corpo” si intendono tutte quelle pratiche che vanno dalla depilazione alla chirurgia plastica, dal lisciare i capelli per le donne africane, al tatuaggio ed i piercing diffusi nell’Occidente. Babiker e Arnold riconoscono due diverse tipologie di tali pratiche estetiche, la prima è quella socialmente accettata che permette all’individuo di raggiungere alcuni ideali di avvenenza fisica. Il secondo tipo è dettato non tanto da motivi estetici quanto dalla voglia di sfidare le convenzioni sociali rasandosi il capo, facendo piercing in punti inusuali o eccedendo in quantità sul viso, facendo tatuaggi che si estendono su tutta la superficie corporea e che vanno, quindi, ben oltre i concetti di “abbellimento” o “moda”. Possiamo trovare un filo conduttore tra queste pratiche estetiche (estreme e non) e l’automutilazione: in entrambi i casi l’individuo crede che nel proprio corpo ci sia qualcosa di sbagliato che deve essere modificato e, soprattutto nel caso più estremo, le modificazioni corporee possono essere viste come un tentativo di esprimere odio verso se stessi.
I comportamenti autodistruttivi come anoressia/bulimia nervosa sono stati spesso studiati in associazione fra loro in quanto si presentano con delle caratteristiche comuni e frequentemente in comorbilità. Entrambe le categorie sono state studiate in connessione con il trauma infantile (abuso sessuale o fisico) ed entrambe possono essere un tentativo di distrazione dal distress opprimente. E’ stato anche dimostrato che i disturbi alimentari e l’automutilazione possono essere l’uno il rimpiazzo dell’altro in quanto molti soggetti riescono a gestire i comportamenti alimentari infliggendosi ferite o viceversa, alcuni cutters possono resistere agli impulsi di tagliarsi sfogandoli nelle abbuffate di cibo.
Nonostante le varie similitudini, il self-injury differisce dagli altri comportamenti autodistruttivi in quanto ai primi segue un danneggiamento corporeo diretto (ad esempio una ferita), nel secondo caso invece il danneggiamento non è diretto ma indiretto in quanto non immediatamente visibile (Ross e McKay, 1979).
Bisogna anche notare che l’atto dell’infliggersi ferite e quello del danneggiarsi in altro modo (per esempio facendo uso di droghe) possono essere distinti in termini di funzioni che svolgono per l’individuo e per la società: l’abuso di stupefacenti è visto dalla comunità come non accettabile ma comprensibile, il gesto automutilante non è accettato né facilmente compreso. Inoltre chi fa uso di droghe o alcol si sente sollevato dal dolore psichico perché assente con la mente a causa dell’effetto della sostanza usata, chi si automutila ottiene sollievo mentre compie l’atto come prodotto dell’atto stesso e non come conseguenza secondaria.
Un’ultima categoria degna di essere confrontata con l’automutilazione è quella che comprende le forme di autolesionismo più marginali come lo stacanovismo, la guida spericolata, l’incorrere in combattimenti e risse. Come accennato precedentemente, la difficoltà di questo paragone sta nel riuscire a tracciare un confine tra ciò che è patologico e ciò che non lo è. La differenza palese la si può ritrovare nell’intento ovvero il fumare una sigaretta danneggia la salute ma l’intento del fumatore non è quello di deteriorare il suo apparato respiratorio mentre quello del cutter che punta la lama di un rasoio sul proprio avambraccio è esattamente quello di recare danno alla propria pelle. Altrettanto evidenti probabilmente non sono le analogie fra i due comportamenti; chi fuma una sigaretta può avere come ragione quella di trovarsi in una situazione stressante da affrontare, lo stesso può accadere al soggetto automutilante. La guida spericolata può essere espressione di rabbia o frustrazione, e le stesse motivazioni possono spingere il cutter a tagliarsi.
Perché ferirsi? Motivazioni soggettive
L’automutilazione, nonostante la connotazione negativa del termine, ha paradossalmente una valenza positiva per il soggetto che la mette in atto. Ma cosa porta una persona a procurasi una ferita per “prendersi cura di sé”? Le motivazioni possono essere tantissime e sono altamente soggettive, vanno dalla strategia di coping all’auto-punizione, dal bisogno di sentirsi vivi alla necessità di espressione di sé.
Strategia di coping
Per molti il self-harm funge da da strumento di salvezza piuttosto che di autodistruzione. Sarebbe quindi una forma di strategia alternativa al suicidio per affrontare le difficoltà, senza la quale non ci sarebbe speranza di sopravvivenza. La vita che viene mantenuta per mezzo dell’automutilazione non è solo quella fisica ma anche, e soprattutto, quella psichica ed emotiva. Una delle funzioni più ampiamente riportate (Strong, 1998) è quella della regolazione del distress e dell’ansia: quando le emozioni negative diventano intollerabili, entra in gioco il ferirsi come tecnica di riduzione della tensione. Per molti dei soggetti il sangue ha una funzione centrale nel calmarsi, è il suo calore che porta a rasserenarsi nei confronti di qualunque forma di ansia da cui essi fossero assaliti. Lo stesso vale per i soggetti che si feriscono per far fronte alla rabbia (Arnold, 1995), spesso non riescono a contenerla o esprimerla quindi non vedono altra scelta se non quella del rivolgerla verso se stessi.
La regolazione di sentimenti inaccettabili non è l’unica funzione che il self-harm può rivestire riguardo il sentirsi travolti dalle emozioni: il dolore fisico autoinflitto può essere una valida ragione per la quale il soggetto si distrae , almeno temporaneamente, dall’agonia emotiva. In effetti il self-injury ha la stessa efficacia che potrebbe avere l’uso di droghe o di alcol ma, a differenza di questi ultimi, non ha pervasivi effetti sulla coscienza, sul lavoro e i risultati di distrazione dal problema sono immediati. Sembra infatti che i pazienti sentano il bisogno imminente di tagliarsi proprio perché vedono in tale comportamento una soluzione rapida e , per lo meno apparentemente, senza altre conseguenze se non quella del danno fisico alla propria persona.
Senso di controllo
L’infliggersi ferite dà al soggetto la consapevolezza di poter fare delle scelte riguardo alla propria vita, di avere autonomia di azione e decisione e di avere, quindi, anche il potere di farsi del male. Queste motivazioni vengono espresse da individui che vivono in ambienti restrittivi che possono essere un penitenziario o una famiglia abusante, circostanze che sono diverse ma paragonabili in termini di sensazioni provate dalla “vittima” ovvero per il bisogno di essere artefice della propria vita, preferendo essere punitore e punito allo stesso tempo invece di subire passivamente il volere di altri.
Con l’espressione “senso di controllo” bisogna intendere anche “senso di realtà” che è spesso ricercata da individui che sperimentano sensazioni di depersonalizzazione e derealizzazione. Tali fenomeni comportano senso di intorpidimento mentale e distacco dal proprio corpo e da ciò che sta accadendo, il self-harm in tal caso porta il soggetto a tornare a sentirsi nuovamente parte della realtà e consapevole.
In altri casi, quelli indicati con l’espressione “self-nurture”, i soggetti usano il self-harm come fosse una sorta di modo per prendersi fisicamente cura del proprio corpo dato che la violenza è l’unica forma di attenzione che hanno ricevuto durante l’infanzia (Levenkron, 1998)
Auto-punizione
Per coloro che fin da bambini hanno appreso un’immagine di sé come di una persona indegna, sporca e cattiva, il self-harm ha la funzione di punizione e allo stesso tempo di espiazione del male compiuto. Il risultato che si ottiene con l’autolesionismo in questo caso , non è di sollievo immediato, bensì la prevenzione dal sentirsi ancora peggio. (Babiker & Arnold, 1997) Considerando se stesso come un peccatore, il self-harmer trova nel ferirsi un modo di convalidare l’idea che ha di se stesso. Se non lo facesse si sentirebbe ancora peggio, per questo motivo la prospettiva terapeutica deve essere improntata non solo sul comportamento in sé ma sulla radicata idea negativa che il paziente ha di se stesso.
Le motivazioni che portano a punire il proprio corpo sono prevalentemente legate alla presenza di una storia di abuso sessuale subito durante l’infanzia. Tali soggetti possono percepire il loro corpo come sporco e degno di essere punito nel momento in cui, durante la pubertà, provano delle pulsioni sessuali che sono interpretate come sbagliate e contraddittorie.
Mezzo di espressione (acting-out, re-enactment)
Le cicatrici ed i segni degli atti di self-harm possono essere sia motivo di vergogna che di orgoglio e, a seconda del valore che assumono, vengono nascoste o esposte. In quest’ultimo caso l’atto autolesivo ha funzione comunicativa, esprime la sofferenza provata dal soggetto in passato a causa di un’esperienza negata o minimizzata per lungo tempo. La cicatrice mostrata ha valore comunicativo chiaro così come potrebbe averlo l’affermazione “questo è quello che mi hanno fatto!”. Nel caso, invece, in cui i segni non vengano esibiti, il self-injury è una ripetizione (re-enactment) del trauma subito (Miller, 1994).
Relazioni con gli altri
Quelle che mi accingo a descrivere sono motivazioni che concernono il mondo interpersonale del self-harmer, queste non sono tanto comuni quanto quelle che riguardano il mondo intrapsichico ma comunque da non sottovalutare. Per alcuni individui il self-harm può supplire alla comunicazione verbale dei loro sentimenti ad altri dato che sono convinti che le sole parole, qualora fossero capaci di utilizzarle per esprimersi, non sarebbero ascoltate o non avrebbero lo stesso effetto (il che è, a mio parere, plausibile). Dall’altra parte, i familiari, gli amici e i colleghi di chi si ferisce hanno reazioni contrastanti e si sentono spesso puniti da tali comportamenti come se in qualche modo ne fossero causa. In realtà non è escluso che il vero obiettivo di chi si ferisce sia esattamente quello di punire l’altro, specialmente nel caso di partner sessuali a seguito di litigi o incomprensioni. Anche facendo l’esempio della “strumentalizzazione” del gesto autolesivo in una relazione, non è da minimizzare la gravità dell’atto perché, se pur con intento manipolativo, il soggetto che esprime se stesso e i suoi bisogni in un modo talmente drastico non può essere considerato solo come l’autore di un ricatto morale o un imbroglio.
Perché ferirsi? Influenze culturali
Proprio considerando la relazione con gli altri, è importante sottolineare che il mondo esterno influisce notevolmente con la messa in atto di comportamenti autolesivi, ci sono delle forti influenze culturali nel gesto ed è stato addirittura ipotizzato una sorta di contagio.
In un campione formato da adolescenti ricoverati per il solo comportamento automutilante, Nock e Prinstein (2005) hanno trovato che il contagio del comportamento era comune perciò hanno ipotizzato che il modellamento sociale possa giocare un ruolo importante nella pratica autolesiva. Gli autori hanno trovato conferma del fatto che l’abitudine di ferirsi sia positivamente rinforzata da fattori esterni, nell’evidenza che l’82% degli adolescenti del loro campione affermarono di avere almeno un amico che nell’anno precedente si era ferito intenzionalmente. Gli adolescenti che si feriscono risultano avere una forte spinta al perfezionismo ma i dati che emergono da questa ricerca non confermano l’ipotesi del perfezionismo orientato a sé bensì solo quello socialmente orientato. Ciò avvalora l’ipotesi secondo la quale le caratteristiche del contesto che circonda il soggetto e della collettività che comprende amici e familiari, abbiano una rilevante influenza sul mantenimento del comportamento di self-harm.
Molti dei nostri comportamenti sono appresi guardando metterli in atto da altri, soprattutto se ci si trova nella situazione di non sapere quale sia la cosa giusta da fare. Se il modello è un personaggio carismatico e famoso, l’effetto imitativo è sicuramente ancora più forte. Per capire quanto importanti possano essere le scene viste in televisione o le parole di una canzone, basti immaginare la situazione di un adolescente e quanto si possa sentire incompreso e perso nel passaggio dall’essere un bambino al dover diventare adulto. Il suicidio di un idolo giovanile come Kurt Cobain, cantante del gruppo rock “Nirvana”, ha shockato e probabilmente influenzato molti adolescenti.
Si pensi al valore suggestivo di una canzone come questa:
Lei teneva in mano uno spillo dalla punta d’argento,
l’accarezzava come fosse l’unica cosa che avesse ancora un senso.
Era bellissima, negli occhi un segno d’invincibile resa.
Troppo tardi capii,
lei distolse lo sguardo dalla mia mano tesa
e si squarciò la guancia come volesse saldare un’offesa.
E disse: mi trovi ancora bella?
( Dead Burger, “La donna più bella in città”)
Quello appena riportato è il teso di una canzone che esprime un esplicito odio di una bella donna verso il proprio corpo, che è esattamente la motivazione che danno le donne che modificano il loro corpo per rivendicarlo.
Tanti sono anche i personaggi famosi che confessano le loro azioni segrete durante interviste o parlandone nei testi delle loro canzoni, ne riporto alcuni esempi:
Stub cigarettes out on my arm / spengo sigarette sul mio braccio
(Maniac Street Preachers, “Roses in the hospital”)
And you bleed just to know you’re alive / e sanguini solo per sapere che sei viva
(Goo Goo Dolls, “Iris”)
Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds
It’s like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me
a volte perfino mi taglio per vedere quanto sanguina / è come adrenalina, il dolore è per me una tale una fretta improvvisa
(Eminem, “Stan”)
got a little red line / ho una piccola linea rossa
That tells you, boy / che ti svela, ragazzo
where the razor’s been / dove è passato il rasoio
(Tori Amos, “Never seen blue”)
I versi di queste canzoni lasciano intendere come oggigiorno l’autolesionismo non sia più qualcosa strettamente inerente a condizioni psicotiche ma lo si ritrovi oramai sempre più spesso rappresentato o raccontato in circostanze quotidiane.
 A proposito di fattori culturali che riguardano l’automutilazione non si può non menzionare il fenomeno della Body Art ovvero “l’arte della modificazione corporea” nata all’inizio degli anni settanta. Questo tipo di arte ha come oggetto non il corpo bensì il tentativo di riappropriarsene abusandone, umiliandolo e facendogli sopportare ogni tipo di violenza. Bende, rasoi, lame, sequenze di autocastrazione e sangue si possono forse definire come i colori ed i pennelli degli artisti della Body Art.
A proposito di fattori culturali che riguardano l’automutilazione non si può non menzionare il fenomeno della Body Art ovvero “l’arte della modificazione corporea” nata all’inizio degli anni settanta. Questo tipo di arte ha come oggetto non il corpo bensì il tentativo di riappropriarsene abusandone, umiliandolo e facendogli sopportare ogni tipo di violenza. Bende, rasoi, lame, sequenze di autocastrazione e sangue si possono forse definire come i colori ed i pennelli degli artisti della Body Art.
Gina Pane, artista performance francese nata negli anni trenta, metteva a rischio la sua vita in ogni performance e spiega coerentemente il concetto di amore espresso con la violenza: “E’ a voi che mi rivolgo perché voi siete […] l’altro. Il corpo ha un ruolo fondamentale nel «noi» […] se apro il mio corpo affinché voi possiate guardarci il mio sangue, è per amore vostro”.
Un altro artista, Franko B., si esibisce in azioni estreme dove è centrale l’assenza di vergogna e la paura, la violenza e il sangue sono ingredienti fondamentali, il suo è un teatro estremo. Non perde mai il controllo sul suo corpo perché esso è, a suo parere, l’unica forma con cui può esprimersi e comunicare. Si incide parole sulla pelle, si taglia e tramite i tagli avverte il senso di libertà che solo il suo sangue sa dargli. Nelle sue performance non potrebbe usare altro sangue se non il proprio infatti, con l’aiuto e la complicità di alcuni medici, raccoglie circa un litro del suo sangue nelle cinque o sei settimane che precedono lo spettacolo, per poi utilizzarlo nelle sue azioni.
Le performance degli artisti moderni non sono state inedite nel loro genere ma possono essere ritrovate nella storia, nelle società ad organizzazione tribale. Fakir Musafar mette in relazione i riti primitivi e i piercing, tatuaggi, scarificazioni moderne definendo tali soggetti come modern primitives. Fakir ha sperimentato su di sé le deformazioni corporali al fine di esplorare gli stadi più profondi del dolore fisico e scoprire l’estasi mentale che ne può derivare: a 13 anni, praticò su se stesso il primo piercing al pene, mentre i primi tatuaggi li fece al liceo. Si è sottoposto ad ogni tipo di modificazione corporea estrema, dallo sdraiarsi su un letto di chiodi, al restare appeso per ore a degli uncini metallici infilati nel petto, dal restringimento del giro-vita indossando un corsetto (esperimento durato per trenta anni) all’allungamento del pene.
Fakir Musafar ha cercato di cogliere il vero significato che ha il tatuaggio per moltissimi giovani che al giorno d’oggi, decidono di averne uno. Per secoli i marchi indelebili sulla pelle hanno rappresentato una protezione dalle malattie come nel caso di Ötzi, un cacciatore vissuto 5300 anni fa, il cui corpo fu ritrovato con più di cinquanta linee tatuate sul corpo e raggruppate in insiemi di quindici su braccia e gambe. Le mummie egiziane presentavano tatuaggi sul corpo a rappresentare status sociale nobile. Nell’antica Roma e Grecia i tatuaggi servivano a marchiare gli schiavi in segno di appartenenza al padrone oppure per segnare sul corpo dei detenuti il tipo di crimine commesso (ad esempio veniva tatuato sulla fronte dei fuggitivi: “Fermami, sono un fuggitivo”) (Gay & Whittington, 2002, Sanders, C. R., 2001). Le motivazioni che spingono un giovane adulto del XX secolo a tatuare il proprio corpo o a forare la propria pelle sono state indagate da coloro che non si sono accontentati della superficiale e sbrigativa risposta “Mi piaceva il disegno”. Andando più a fondo molti autori (ad esempio Fakir Musafar, in Favazza, 1996; Gold et al., 2005; Hewitt, 1997; Reyntjens, 2002; Stewart, 2000) sono riusciti a risalire a motivazioni più profonde, come se il tatuaggio e il suo vero significato potessero riflettere il “mondo interno” del soggetto.
Per alcuni il piercing o il tatuaggio sono una forma di espressione di sé, per altri può simbolizzare la volontà di ricordare un evento o un’esperienza importante della loro vita, per i cadetti militari americani è un rito di passaggio e così via. Altre ricerche hanno suggerito che gli stressor psicosociali, come l’esposizione ad un trauma, possono essere associati al ricorrere a modificazioni corporee. Ad esempio Jeffreys (2000) e Martin (1997) (in Roberti, Storch, & Bravata, 2004) affermano che donne che hanno subito dei traumi come l’abuso sessuale, hanno probabilità più alte delle altre di tatuare o forare il loro corpo in più occasioni. Le vittime di abuso sessuale hanno significativamente una minore autostima e presentano un maggior numero di tatuaggi così come un maggior distress e comportamenti di self-harm (Reyntijens, 2002). Allo stesso tempo però, le donne abusate che hanno molti tatuaggi hanno un livello di stima del proprio corpo uguale a quello dei soggetti senza una storia di abuso il che può essere interpretato come un uso terapeutico del tattoo. In effetti il numero di tatuaggi e la grandezza della superficie corporea che essi rivestono sono positivamente correlati con l’autostima, è come se le donne che sono state abusate cercassero di riappropriarsi del proprio corpo marchiandolo indelebilmente.
Le body modifiers violano e si ribellano non solo alle norme di bellezza ma anche alla strumentalizzazione e vittimizzazione del corpo femminile attuata da secoli dalla nostra società a stampo patriarcale. Questa riappropriazione del proprio corpo trova supporto nella subcultura della body art ma è stata più volte criticata in quanto vista più come auto-mutilazione che come auto-cura. Le donne che tatuano la loro pelle in modo tanto esagerato da andare ben oltre il semplice abbellimento corporeo, riescono perfettamente a tracciare una linea distintiva tra il loro comportamento e quello automutilativo: secondo loro ogni modificazione che fanno è controllata, sicura e porta ad una crescita personale, il che non sarebbe da paragonare ai comportamenti autolesivi fini a se stessi che sono attuati senza alcuna intenzione positiva (Pitts, 2003). Il reclamare il possesso del proprio corpo modificandone l’aspetto, non lo riporta ad essere il corpo pre-vittimizzato, non lo guarisce. Secondo la sociologa Pitts il reclamare il corpo deve essere interpretato come una reale produzione piuttosto che come una guarigione.
In realtà, avvalendosi della definizione di Favazza, tatuare il proprio corpo rientra fra le pratiche culturalmente sancite. Non c’è allora da fare alcuna distinzione fra una donna con il volto ricoperto da piercing e tatuaggi ed una che ha seguito invece la sola pratica culturale di forare i lobi per indossare gli orecchini? E se la distinzione viene fatta in questo caso, che dire della suddetta donna con molteplici modificazioni corporee messa a paragone con un self-cutter? Le motivazioni che spingono i due soggetti possono essere simili, dove allora va tracciata la linea fra il sano ed il patologico? Credo che sia importante far notare che, se è vero che le modificazioni del proprio corpo in segno di riappropriazione vengono esposte e cercano di essere il più evidenti possibile, la maggior parte di queste donne hanno dei piercing, tatuaggi o scarificazioni che sono tutt’altro che pubbliche. I piercing al clitoride o sui capezzoli sono letteralmente privati, quindi il tipo di protesta che si appoggia alla body art e che ha pretese di ribellione pubblica è, a mio parere, fondata su un simbolismo personale più che collettivo.
Riprendendo il concetto di “produzione” della Pitts, credo che la body modification possa essere paragonata alla self-mutilation in quanto entrambe possono essere viste come un tentativo di auto-aiuto, di auto-cura. Per una donna che ha subito un abuso sessuale, l’essere stata usata, oppressa, vittimizzata e stuprata fa parte della sua identità e della sua biografia. Il modificare quel corpo di cui altri hanno abusato può segnare un punto di ricostruzione dell’immagine di sé non più solo come vittima o sopravvissuta ma come donna e persona che possiede il proprio corpo. La testimonianza di una delle clienti di Fakir Musafar rende l’idea del punto di vista di queste donne: “Mi sto facendo il piercing per riscattare il mio corpo. Sono stata usata e abusata. Il mio corpo è stato preso da un altro senza il mio consenso. Ora, tramite il rituale del piercing, rivendico il mio corpo come mio. Guarisco le mie ferite.”
Molto interessante riguardo al rapporto tra l’automutilazione e la presenza di modificazioni corporee, è lo studio di Reyntjens (2002) nel quale è stata riscontrata la presenza di comportamenti di self-harm in 112 donne su 150 e alti livelli di tali atti in 52 soggetti (75% delle quali presentavano tatuaggi). Un altro studio, condotto in Alabama da Dhossche (2000), ha dimostrato l’alta incidenza di casi di suicidio fra i soggetti tatuati rispetto a quelli che non lo sono; secondo gli autori gli individui con tatuaggi avrebbero più alte possibilità di morire a causa di suicidio invece che di morte accidentale (57% rispetto al 29% del campione).
Questi dati, per quanto discutibili, dovrebbero indurre a capire come il problema del self-harm non sia da circoscrivere al solo cutter o burner che si ferisce in privato ma bisognerebbe prestare più attenzione ai soggetti che, al di là delle mode e delle subculture, modificando radicalmente il loro aspetto, possono manifestare il loro disagio psichico.
dott.ssa Paola Marangio
psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare
paolamarangio@gmail.com
fonte immagini: web
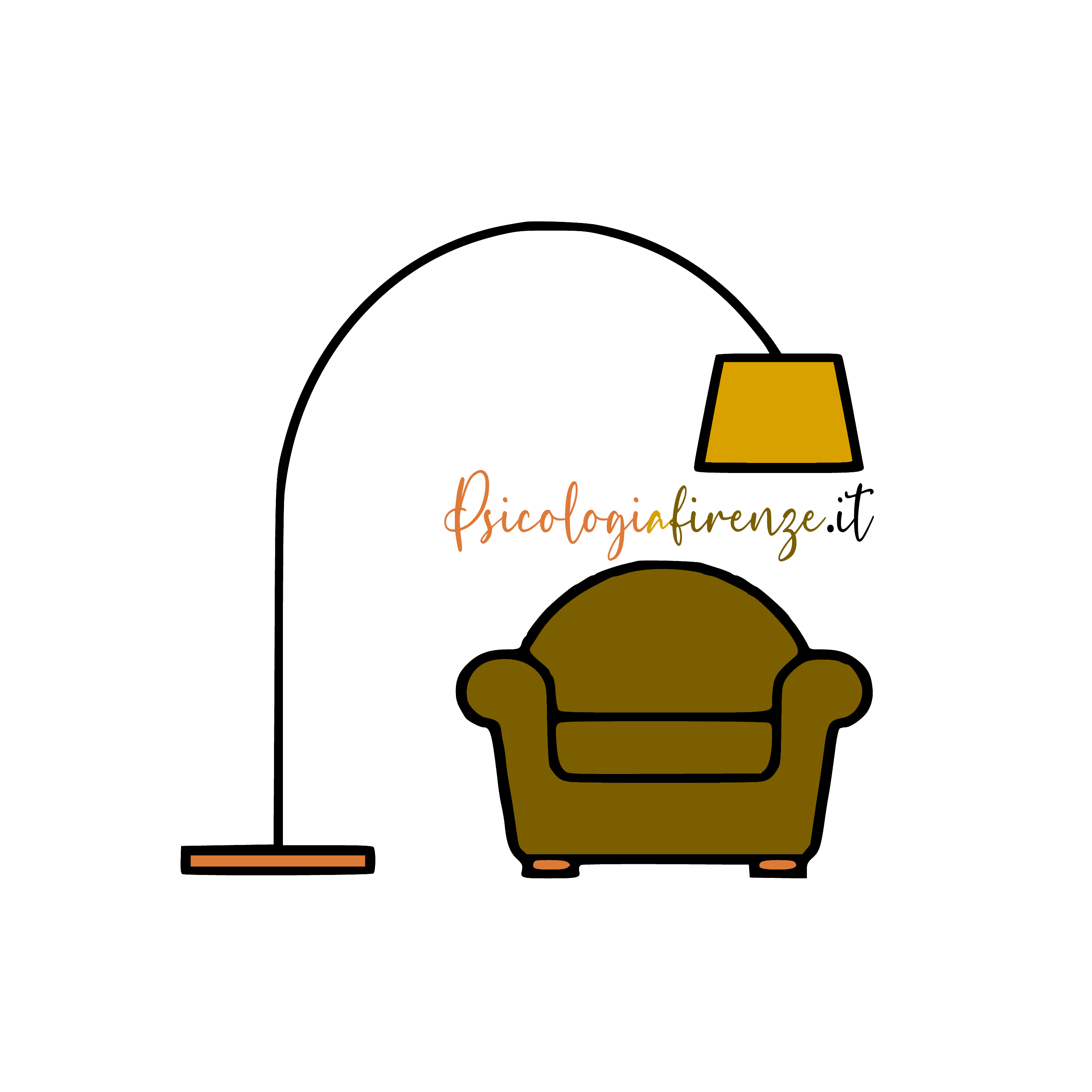
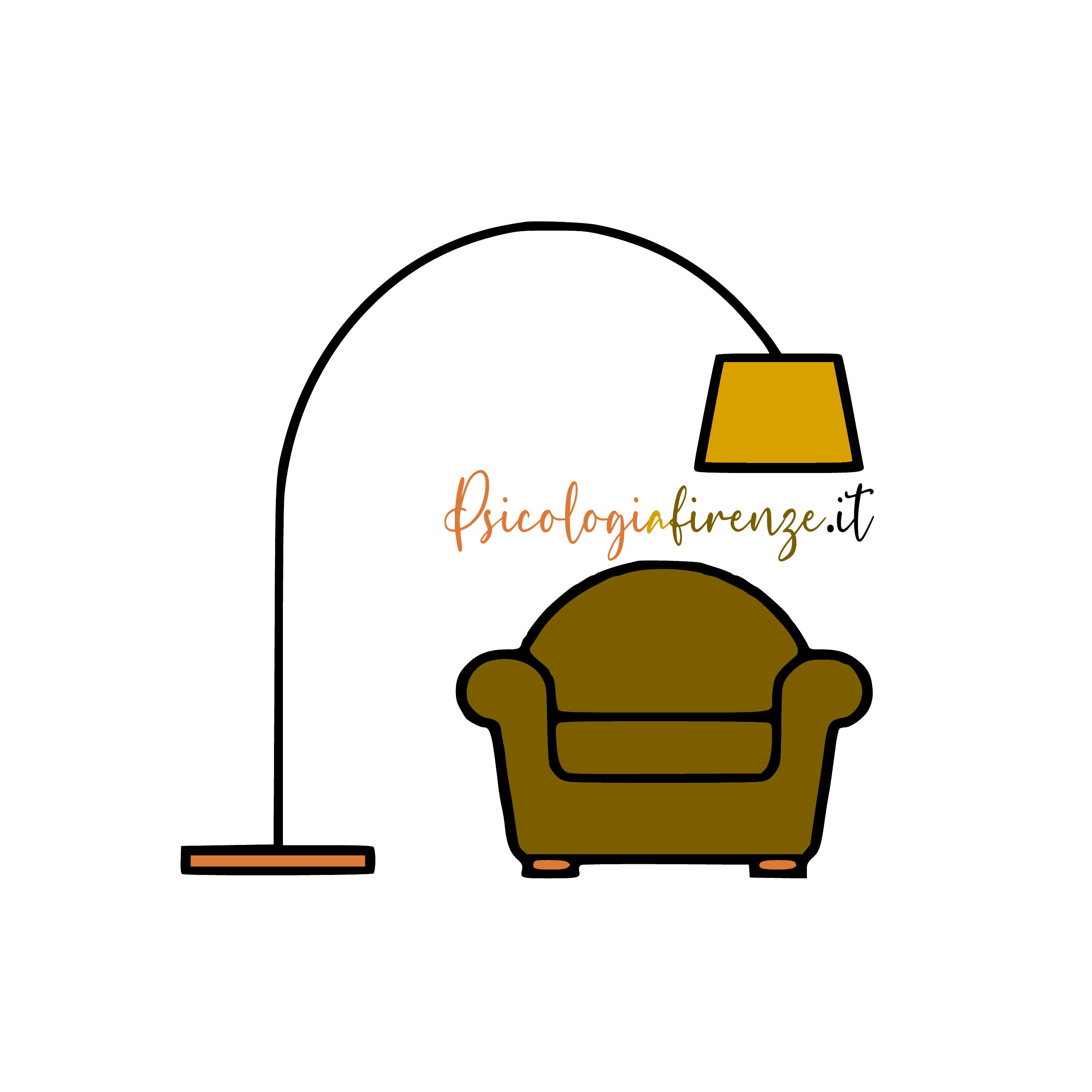


No responses yet